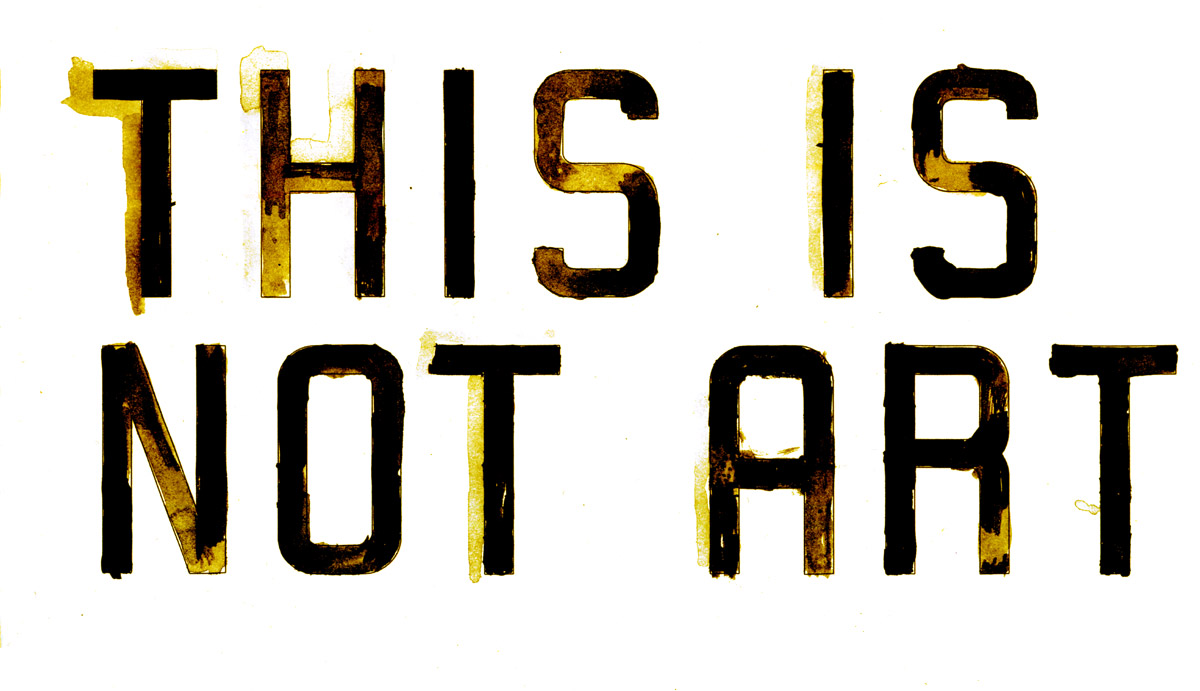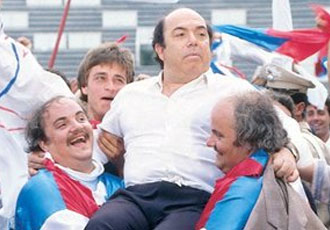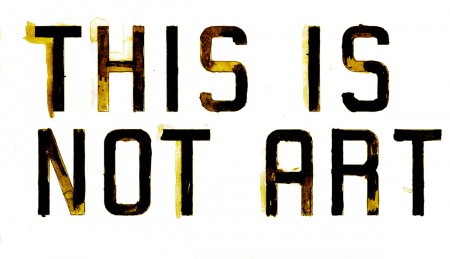 Il linguaggio ha i suoi meccanismi e quando si entra nello specifico è possibile scoprire un mondo di sottoinsiemi che in sostanza regolano il nostro modo di esprimerci. A volte però questi meccanismi, queste consuetudini finiscono per trasformare ogni conversazione ed ogni scritto in una serie di luoghi comuni assai buffi. Prendete ad esempio le interviste agli allenatori di calcio, anche se la loro squadra è destinata a scontrarsi con l’ultima in classifica, le loro dichiarazioni saranno sempre caratterizzate da un turbinio di frasi del tipo “Sarà una partita dura, non esistono più le squadre cuscinetto, loro cercano il riscatto e ci daranno filo da torcere”.
Il linguaggio ha i suoi meccanismi e quando si entra nello specifico è possibile scoprire un mondo di sottoinsiemi che in sostanza regolano il nostro modo di esprimerci. A volte però questi meccanismi, queste consuetudini finiscono per trasformare ogni conversazione ed ogni scritto in una serie di luoghi comuni assai buffi. Prendete ad esempio le interviste agli allenatori di calcio, anche se la loro squadra è destinata a scontrarsi con l’ultima in classifica, le loro dichiarazioni saranno sempre caratterizzate da un turbinio di frasi del tipo “Sarà una partita dura, non esistono più le squadre cuscinetto, loro cercano il riscatto e ci daranno filo da torcere”.
Ebbene signori non stupitevi più di tanto poichè questi meccanismi sono largamente utilizzati anche nel mondo dell’arte contemporanea e molto spesso giornalisti, critici e storici rimangono impigliati in frasi circostanziali che oramai hanno perso significato, che non comunicano più nulla e proprio per il loro largo uso finiscono per distrarre il lettore. Andiamo a vedere quali sono i termini e le frasi più gettonate all’interno di testi e discorsi d’arte: